”Sara’ una sequenza sismica lunga, che potrebbe durare mesi o anni, con sequenze di magnitudo confrontabile alla scossa principale”, ha detto oggi il presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), Stefano Gresta, nella conferenza stampa organizzata dall’istituto all’indomani del terremoto di magnitudo 5,8 nel modenese. “Come abbiamo detto fin dal 20 maggio la sequenza ha tutte le caratteristiche di una sequenza che si ripete con la maggioranza dei terremoti di magnitudo decrescente, ma con momenti di recrudescenza, non è quindi possibile stabilire l’esatta evoluzione nel tempo e non si possono escludere repliche di magnitudo 4 o 5, confrontabili anche con quelle forti del 20 e 29 maggio“, ha aggiunto il presidente dell’Ingv.
”Dal punto di vista scientifico – ha proseguito Gresta – la sequenza rimanda a conoscenze passate” perche’ ”il terremoto e’ avvenuto in un’area che per centinaia di anni non ha visto terremoti. Per questo – ha aggiunto – dobbiamo fare un atto di umilta’ e recuperare documenti storici”. In questo caso il punto di riferimento e’ la descrizione del terremoto avvenuto nella stessa area nel 1570, ricostruita nel 1905 dal sismologo Mario Baratta. Da quei documenti emerge che le scosse durarono per nove mesi, nei quali non vi fu una giornata senza un terremoto percepibile dalla popolazione, dopidiche’ il ritmo delle scosse comincio’ a rallentare, stabilizzandosi per i quattro anni successivi. Solo a partire dal 1574 il ritmo comincio’ a ridursi ed i terremoti cessarono nel 1576.
 CIRCA 1.000 SCOSSE DAL 20 MAGGIO, TUTTE CON LO STESSO MECCANISMO FOCALE – Sono stati circa un migliaio le scosse di terremoto avvenute in Emilia a partire dal 20 maggio. Di queste, più recenti concentrate nella zona occidentale, la maggior parte avvenute a partire dalla mezzanotte oscilla fra magnitudo 2 e 3. Sono i dati forniti oggi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv).”Le scosse registrate finora rientrano in un quadro di normale sismicità” ha detto il presidente dell’Ingv, Stefano Gresta. Per il sismologo Alessandro Amato “è importante non abbassare la guardia,la sequenza durerà molto tempo“. ”Il meccanismo focale del sisma di ieri è uguale a quello del 20 maggio: il processo cinematico è unico, non ci sono state attivazioni di faglie discordi” ha aggiunto Gresta. Quanto all’ipotesi di attivazione di una seconda faglia, l’esperto taglia corto: ”è una questione di lana caprina: vanno analizzati i dati, occorre verificare e ci metteremo qualche anno. I dati che abbiamo non autorizzano a pensare che si sia attivata la seconda faglia, e anche il meccanismo delle scosse di ieri è identico a quello delle prime” dunque l’Istituto tenderebbe a escludere questa evenienza. Il presidente dell’Ingv ricorda il terremoto del 1570 nella stessa zona: ”Ci furono anni di scosse. Il quadro che abbiamo di fronte ripeterà ciò che è successo nel passato. Non dobbiamo aspettarci però -sottolinea- scosse maggiori di magnitudo 6”. Quanto alle mappe di pericolosità, l’Ingv ricorda che si tratta di calcoli probabilistici e che la pericolosità è cosa differente dal rischio: ”Il 40% dei terremoti distruttivi, in tutto il mondo, ricade in aree a non elevata pericolosità”. Concetto ripetuto da Alessandro Amato, dirigente ricercatore e ‘cuore’ della sala sismica dell’Ingv: ”Tra pericolosità e rischio c’è molta differenza: il problema italiano è la vulnerabilità, se le case sono costruite male il rischio diventa immenso anche in zone a bassa pericolosità” in caso anche di sismi non significativi.
CIRCA 1.000 SCOSSE DAL 20 MAGGIO, TUTTE CON LO STESSO MECCANISMO FOCALE – Sono stati circa un migliaio le scosse di terremoto avvenute in Emilia a partire dal 20 maggio. Di queste, più recenti concentrate nella zona occidentale, la maggior parte avvenute a partire dalla mezzanotte oscilla fra magnitudo 2 e 3. Sono i dati forniti oggi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv).”Le scosse registrate finora rientrano in un quadro di normale sismicità” ha detto il presidente dell’Ingv, Stefano Gresta. Per il sismologo Alessandro Amato “è importante non abbassare la guardia,la sequenza durerà molto tempo“. ”Il meccanismo focale del sisma di ieri è uguale a quello del 20 maggio: il processo cinematico è unico, non ci sono state attivazioni di faglie discordi” ha aggiunto Gresta. Quanto all’ipotesi di attivazione di una seconda faglia, l’esperto taglia corto: ”è una questione di lana caprina: vanno analizzati i dati, occorre verificare e ci metteremo qualche anno. I dati che abbiamo non autorizzano a pensare che si sia attivata la seconda faglia, e anche il meccanismo delle scosse di ieri è identico a quello delle prime” dunque l’Istituto tenderebbe a escludere questa evenienza. Il presidente dell’Ingv ricorda il terremoto del 1570 nella stessa zona: ”Ci furono anni di scosse. Il quadro che abbiamo di fronte ripeterà ciò che è successo nel passato. Non dobbiamo aspettarci però -sottolinea- scosse maggiori di magnitudo 6”. Quanto alle mappe di pericolosità, l’Ingv ricorda che si tratta di calcoli probabilistici e che la pericolosità è cosa differente dal rischio: ”Il 40% dei terremoti distruttivi, in tutto il mondo, ricade in aree a non elevata pericolosità”. Concetto ripetuto da Alessandro Amato, dirigente ricercatore e ‘cuore’ della sala sismica dell’Ingv: ”Tra pericolosità e rischio c’è molta differenza: il problema italiano è la vulnerabilità, se le case sono costruite male il rischio diventa immenso anche in zone a bassa pericolosità” in caso anche di sismi non significativi.
 IERI BEN 16.000 SEGNALAZIONI SUL SITO “HAISENTITOILTERREMOTO” – Sedicimila questionari arrivati solo nella giornata di ieri: è questa la risposta degli utenti al servizio www.haisentitoilterremoto.it dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, dopo le nuove scosse in Emilia Romagna. Una piattaforma partecipativa, di servizio, creata dall’Ingv nel 1997 quando ancora le potenzialità della rete e dei social network erano lontane, esplosa numericamente durante il terremoto all’Aquila e in Abruzzo. Qualunque utente che vuole dare informazioni sul terremoto, digitando l’indirizzo Internet, può compilare un questionario e mandare le proprie osservazioni e testimonianze su un sisma in corso. Tutti i questionari sono filtrati per capire l’attendibilità e poi convogliati in una mappa che disegna l’epicentro, le zone colpite e l’intensità del sisma. Dal 2007 ad oggi sono stati elaborati oltre 400mila questionari che hanno prodotto informazioni su oltre 4200 terremoti avvertiti in Italia il cui epicentro è sul territorio e, per i terremoti più forti, anche fuori dall’Italia (ad es. in Grecia). ”E’ un esempio di informazione bidirezionale, che dal singolo viene trasmessa ad un’intera comunità. Un grande database che si trasforma in grafici e mappe che sono abbastanza attendibili e sovrapponibili a quelle tracciate dai sismografi”, spiega Valerio De Rubeis dell’Ingv ideatore della piattaforma insieme a Patrizia Tosi.
IERI BEN 16.000 SEGNALAZIONI SUL SITO “HAISENTITOILTERREMOTO” – Sedicimila questionari arrivati solo nella giornata di ieri: è questa la risposta degli utenti al servizio www.haisentitoilterremoto.it dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, dopo le nuove scosse in Emilia Romagna. Una piattaforma partecipativa, di servizio, creata dall’Ingv nel 1997 quando ancora le potenzialità della rete e dei social network erano lontane, esplosa numericamente durante il terremoto all’Aquila e in Abruzzo. Qualunque utente che vuole dare informazioni sul terremoto, digitando l’indirizzo Internet, può compilare un questionario e mandare le proprie osservazioni e testimonianze su un sisma in corso. Tutti i questionari sono filtrati per capire l’attendibilità e poi convogliati in una mappa che disegna l’epicentro, le zone colpite e l’intensità del sisma. Dal 2007 ad oggi sono stati elaborati oltre 400mila questionari che hanno prodotto informazioni su oltre 4200 terremoti avvertiti in Italia il cui epicentro è sul territorio e, per i terremoti più forti, anche fuori dall’Italia (ad es. in Grecia). ”E’ un esempio di informazione bidirezionale, che dal singolo viene trasmessa ad un’intera comunità. Un grande database che si trasforma in grafici e mappe che sono abbastanza attendibili e sovrapponibili a quelle tracciate dai sismografi”, spiega Valerio De Rubeis dell’Ingv ideatore della piattaforma insieme a Patrizia Tosi.
 LE CASE SONO CROLLATE PER I “VULCANI DI SABBIA” – Sono stati anche i cosiddetti ”vulcani di sabbia” a provocare il cedimento di molte abitazioni in seguito ai terremoti che si stanno susseguendo dal 20 maggio in Emilia. ”E’ un fenomeno dovuto alla liquefazione della sabbia che avviene nel sottosuolo, sotto la spinta di una fortissima pressione”, ha spiegato la ricercatrice dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) Paola Montone, appena rientrata da una prima campagna di rilievi nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio. Nella conferenza stampa organizzata oggi a Roma dall’Ingv, Montone ha spiegato che i vulcani di sabbia si formano ”soltanto in condizioni molto particolari. Avvengono quando nel sottosuolo, anche a pochissima profondità, si trovano strati di sabbia e argilla, come accade nella Pianura Padana”. Anche a profondità di un metro o un metro e mezzo la sabbia, sottoposta ad una pressione molto forte, può passare dallo stato solido e compatto allo stato liquido. Questo accade, ha spiegato la ricercatrice, perché l’acqua imprigionata nei pori dei grani di sabbia non è comprimibile e in risposta alla forte pressione la sabbia si trasforma in una sorta di fluido (o liquido pesante) e sale in superficie, formando i vulcani. E’ per questo, ha proseguito, che nelle zone del ferrarese del modenese colpite dal terremoto e’ facile vedere successioni di piccoli vulcani, ognuno dei quali delle dimensioni di decine di centimetri, allineati in corrispondenza di fratture lunghe anche fino a 500 metri. ”E’ un fenomeno molto esteso – ha rilevato – e che costituisce un pericolo per le case”: nel momento in cui la sabbia sale in superficie il terreno cede. I vulcani di sabbia non sono una caratteristica presente solo nella Pianura Padana. Sono stati osservati per esempio nel terremoto de L’Aquila del 2009, in Sicilia, in Calabria e sono stati documentati anche in Puglia, nel terremoto che ha colpito il Gargano nel 1627
LE CASE SONO CROLLATE PER I “VULCANI DI SABBIA” – Sono stati anche i cosiddetti ”vulcani di sabbia” a provocare il cedimento di molte abitazioni in seguito ai terremoti che si stanno susseguendo dal 20 maggio in Emilia. ”E’ un fenomeno dovuto alla liquefazione della sabbia che avviene nel sottosuolo, sotto la spinta di una fortissima pressione”, ha spiegato la ricercatrice dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) Paola Montone, appena rientrata da una prima campagna di rilievi nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio. Nella conferenza stampa organizzata oggi a Roma dall’Ingv, Montone ha spiegato che i vulcani di sabbia si formano ”soltanto in condizioni molto particolari. Avvengono quando nel sottosuolo, anche a pochissima profondità, si trovano strati di sabbia e argilla, come accade nella Pianura Padana”. Anche a profondità di un metro o un metro e mezzo la sabbia, sottoposta ad una pressione molto forte, può passare dallo stato solido e compatto allo stato liquido. Questo accade, ha spiegato la ricercatrice, perché l’acqua imprigionata nei pori dei grani di sabbia non è comprimibile e in risposta alla forte pressione la sabbia si trasforma in una sorta di fluido (o liquido pesante) e sale in superficie, formando i vulcani. E’ per questo, ha proseguito, che nelle zone del ferrarese del modenese colpite dal terremoto e’ facile vedere successioni di piccoli vulcani, ognuno dei quali delle dimensioni di decine di centimetri, allineati in corrispondenza di fratture lunghe anche fino a 500 metri. ”E’ un fenomeno molto esteso – ha rilevato – e che costituisce un pericolo per le case”: nel momento in cui la sabbia sale in superficie il terreno cede. I vulcani di sabbia non sono una caratteristica presente solo nella Pianura Padana. Sono stati osservati per esempio nel terremoto de L’Aquila del 2009, in Sicilia, in Calabria e sono stati documentati anche in Puglia, nel terremoto che ha colpito il Gargano nel 1627


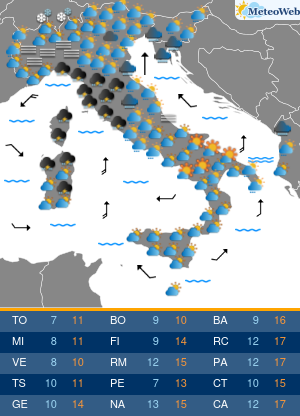


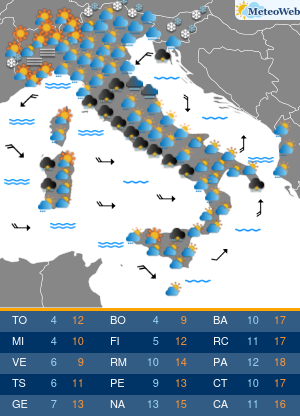


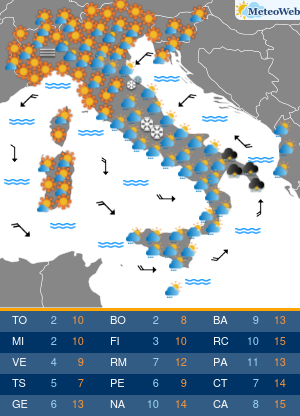


 Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?
Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?