Dopo gli ultimi eclatanti eventi del Dicembre 2004 (Oceano Indiano) e del Marzo 2011 (Giappone) tutti ormai sanno che il termine tsunami è di origine giapponese e significa “onda nel porto”. Rappresenta dunque un movimento anomalo del mare che colpisce la costa. Molti profani ritengono che uno tsunami possa essere generato esclusivamente da un terremoto. In realtà non è così: certo, la scossa sismica (sia che avvenga in terraferma o in mare aperto) è la causa principale nella genesi di un maremoto, ma non è l’unica possibile. La statistica ci dice che, a livello mondiale, oltre il 90% degli tsunami è generato da un terremoto che però deve avere particolari caratteristiche: una magnitudo di almeno 6.5, una profondità focale non troppo elevata e provocare uno spostamento verticale del fondo marino che inneschi il movimento della massa d’acqua soprastante. Ma la restante percentuale di tsunami è dovuta ad altri eventi particolari: eruzioni vulcaniche (subaeree o sottomarine), grandi frane (subaeree o sottomarine) in prossimità della costa, impatti sulla superficie marina di corpi celesti (meteoriti), perfino particolari eventi meteorologici con trasferimento di energia per risonanza dall’atmosfera al mare. In questo specifico caso l’Italia rappresenta un’anomalia interessante: nel nostro paese infatti, secondo i dati storici e scientifici, la percentuale di tsunami dovuti a cause non sismiche risulta superiore, e non di poco, rispetto al resto del mondo. Generalmente gli tsunami non generati da terremoti risultano soggetti ad una più rapida dissipazione ovvero perdono energia più rapidamente degli altri. Ma quali sono i termini, scientifici e non, più comunemente associati allo sviluppo di uno tsunami? Per rispondere a questa domanda, ecco un piccolo glossario, destinato a chi vuole avere maggiore dimestichezza con le problematiche connesse allo studio degli tsunami.
ASTEROIDE: corpo celeste, generalmente posizionato tra Marte e Giove, che percorre una propria orbita attorno al sole, con caratteristiche fisiche similari ai pianeti, di diametro variabile (da 1000 a 20 km). La maggior parte dei meteoriti è costituita da asteroidi
BATIMETRIA: sezione dell’oceanografia che si occupa di ricostruire l’andamento morfologico del fondo marino ovvero la profondità dei fondali in ogni punto. Tra gli strumenti più utilizzati l’ecoscandaglio, il laser e la sismica a riflessione. La profondità del fondo marino è un fattore fondamentale per amplificare o diminuire gli effetti di uno tsunami, in particolare di quelli connessi ai fenomeni meteorologici. In caso di maremoto generato da frana sottomarina, le analisi batimetriche sono indispensabili per la ricostruzione esatta dell’evento come nel caso dello tsunami nello Stretto di Messina del 1908
CAVO: la parte bassa dell’onda, il “vuoto” compreso fra due creste successive. Se, in caso di tsunami, sulla costa arriva prima il cavo, si assiste al ritiro del mare
EPICENTRO: la verticale sulla superficie terrestre dell’ipocentro
ERUZIONE: espulsione di materiale vulcanico (lava, prodotti piroclastici, gas) sulla superficie terrestre. Viene classificata in base alla sua tipologia: pliniana (da Plinio il Giovane che descrisse l’eruzione vesuviana del 79, esplosiva e con fuoriuscita di prodotti piroclastici); peleana (con ostruzione del condotto causa un magma molto vischioso, molto esplosiva e con flussi piroclastici violenti, da Pelée, vulcano della Martinica teatro di una violentissima eruzione nel 1902); vulcaniana (da Vulcano, violenta e con prodotti piroclastici anche di grandi dimensioni); stromboliana (da Stromboli, con alternanza di esplosioni e fuoriuscita di lava); hawaiana (fuoriuscita continua di lava in lunghissime colate ma senza esplosioni, tipica delle isole Hawaii); freatica (esplosioni di gas dovute al riscaldamento di acque sotterranee, senza emissione di magma)
FAGLIA: frattura della superficie terrestre con movimento relativo delle due porzioni di roccia. Si classifica in base alle caratteristiche del movimento delle due porzioni: diretta, inversa, trascorrente. Quest’ultimo tipo, caratterizzato da un piano di faglia verticale, ha una minor capacità di generare tsunami rispetto agli altri due
FRANA: fenomeno di caduta e/o movimento gravitativo, rapido o lento, di masse rocciose e/o materiali sciolti, con conseguenti modifiche alla morfologia del territorio su cui si sviluppa. Viene classificata in base alle sue caratteristiche (crollo, scivolamento, scoscendimento, colamento, ecc.) e la sua genesi è dovuta anche a particolari fenomeni naturali quali erosione, terremoti, eruzioni, azione delle acque, precipitazioni meteoriche
INGRESSIONE: l’invasione della costa da parte del mare. La massima ingressione sulle nostre coste è stata accertata nel 1627, nello tsunami del Gargano, quando il mare penetrò per circa 3 km. Il termine opposto è la regressione
INONDAZIONE: straripamento di acque (fluviali, lacustri, marine) che penetrano in luoghi generalmente non allagati. Sinonimi: esondazione, alluvione, allagamento. In Italia la massima inondazione di un lago nei territori circostanti dovuta ad un terremoto, s’è verificata nel Lago di Bolsena nel 1695 le cui acque coprirono le campagne circostanti per circa 3 km
INTENSITA’: il potenziale distruttivo di uno tsunami. Si misura attraverso la scala Ambraseys-Sieberg e non dipende esclusivamente dall’altezza dell’onda ma bensì soprattutto dai volumi di acqua mobilizzati
IPOCENTRO: il punto ideale all’interno della terra in cui si genera un terremoto e dunque sorgente privilegiata per uno tsunami
LUNGHEZZA D’ONDA: distanza tra due creste d’onda successive (o tra due cavi successivi). Quella di uno tsunami generato da un terremoto varia generalmente tra 20 e 300 km, quella di uno tsunami generato da una frana oscilla in genere tra qualche centinaio di metri e 10 km. Valori comunque sempre nettamente maggiori alle onde marine generate dal vento che di solito hanno lunghezze d’onda comprese tra 100 e 200 metri associate a periodi di 5-20 secondi: ciò rappresenta il principale fattore discriminante tra i due fenomeni
MAGNITUDO: l’energia sprigionata da un terremoto. Misurata per molti anni (simbolo M) tramite la Scala Richter. Oggi si tende a registrare la magnitudo (Mw) secondo la Moment Magnitude Scale ovvero la Scala di Magnitudo del Momento Sismico. Entrambe le scale, a differenza della Scala Mercalli (da tempo in disuso), non sono decimali ma logaritmiche perciò la differenza di un’unità implica un potenziale energetico di circa 31 volte maggiore o minore. Molti autori considerano la soglia di magnitudo 6.5 come il limite minimo affinché si possa verificare uno tsunami
MAREMOTO: il termine italiano corrispondente a tsunami. Sta però lentamente cadendo in disuso, anche e soprattutto a livello scientifico
MAREOGRAFO: strumento atto alla misura delle oscillazioni del livello marino. Le sue registrazioni forniscono grafici chiamati mareogrammi, molto simili ai sismogrammi di un terremoto. Dallo studio dei mareogrammi si possono ottenere informazioni estremamente importanti per la ricostruzione scientifica di uno tsunami
METEORITE: massa rocciosa (spesso un asteroide) proveniente dallo spazio interplanetario che attraversa l’atmosfera terrestre ed impatta la superficie del nostro pianeta. La meteora invece è un corpo celeste che non riesce a raggiungere la superficie terrestre perché si disintegra incendiandosi nell’atmosfera. Secondo la teoria più accreditata, la celebre estinzione dei dinosauri sarebbe dovuta proprio alla caduta di un immenso meteorite, tale da provocare immani sconvolgimenti climatici, nell’attuale Golfo del Messico, nei pressi della penisola dello Yucatan
ONDA: la forma che assume la trasmissione dell’energia in un qualsiasi mezzo fisico, ad esempio meccanico, elettromagnetico o, come nel caso di uno tsunami, liquido. Le onde di uno tsunami hanno caratteristiche similari ma differenti rispetto alle onde generate normalmente dal vento: posseggono infatti una lunghezza d’onda (la distanza tra due creste successive) ed un periodo (il tempo necessario al passaggio di due onde successive) ben maggiori. Inoltre, a differenza delle onde marine normali, le ondate di tsunami non esauriscono immediatamente tutta la loro energia nell’impatto sulla costa
PERIODO: tempo intercorso tra l’arrivo in un punto di due creste d’onda successive (o di due cavi successivi). In caso di tsunami rappresenta anche il tempo che intercorre tra il ritiro del mare e la sua ingressione sulla costa: in genere oscilla tra 5 minuti e due ore
PLACCA: enorme porzione di litosfera (la parte più esterna del nostro pianeta, costituita da crosta terrestre e mantello superiore). Essendo rigide, le placche si comportano come se galleggiassero sulla sottostante astenosfera, con movimenti relativi di qualche cm all’anno. A causa di tali movimenti reciproci, nelle zone di contatto tra le placche (teoria della tettonica a zolle) si originano terremoti
PTWS: acronimo di Pacific Tsunami Warning System, il sistema di allarme del Pacifico. Si attiva soltanto in occasione di terremoti con magnitudo pari o superiore a 6.5
RISCHIO: la probabilità che uno tsunami colpisca una determinata zona. Sulle coste italiane il rischio-tsunami è più elevato di quello che crede l’opinione pubblica. Negli ultimi duemila anni sono infatti una settantina i maremoti che hanno colpito il nostro paese, non tutti di grande intensità ma capaci comunque a più riprese di generare danni ingenti e vittime umane: considerando gli ultimi 500 anni (dove i riferimenti bibliografici e storici sono migliori), in un secolo la loro media oscilla tra 15 e 20. Geograficamente le aree più a rischio in Italia sono la Sicilia Orientale, lo Stretto di Messina, la Calabria Meridionale, le isole Eolie, il Golfo di Napoli. In epoca storica si sono segnalati tsunami di una certa entità anche nel Gargano, in Liguria ed in Romagna. Dunque, praticamente tutti i mari d’Italia sono potenzialmente soggetti ad uno tsunami
RITIRO (o regressione): spesso uno tsunami è “annunciato” dal ritiro del mare ma non accade sempre così. Il ritiro infatti si verifica solo nel caso in cui ad arrivare prima sulla costa è il cavo, ovvero la parte “negativa” dell’onda. Se invece arriva prima la parte “positiva”, cioè la cresta, non si verifica ritiro che rimane comunque l’evento premonitore più importante di uno tsunami
RUN-UP: altezza dell’onda di uno tsunami ovvero la distanza verticale tra cavo e cresta. Il più grande run-up mai osservato si sviluppò il 9 Luglio 1958 in Alaska, nella baia di Lituya, a seguito di un violento terremoto che provocò un’immensa frana (volume 30 milioni di metri cubi): le aree boschive circostanti la baia furono distrutte dalle onde fino ad un’altezza di 516 m dal livello del mare! In Italia invece il valore massimo di run-up provocato da uno tsunami è stato registrato nello Stretto di Messina nel 1908, con circa 12 metri. Non sempre però il primo run-up, associato alla prima onda, risulta il maggiore: si segnalano infatti numerosi casi in cui le onde successive sono state caratterizzate da run-up più alti
SCALA AMBRASEYS-SIEBERG: prende il nome dai due scienziati che l’hanno prima ideata (Sieberg 1927) e poi ottimizzata (Ambraseys 1962). Identifica l’intensità di uno tsunami sulla base delle sue caratteristiche e dei danni provocati. Va da 1 (molto debole ed avvertito solo dai mareografi) a 6 (disastroso con inondazione della costa e numerose vittime umane)
SENSORE-BOA: strumento atto alla misura dell’altezza d’onda e quindi alla valutazione di eventuali onde anomale, poco utile però nel caso in cui sorgente e costa siano vicini (ad esempio Stromboli-coste calabresi e siciliane) dato il limitato tempo a disposizione per organizzare eventuali evacuazioni. Nel nostro paese il sistema di monitoraggio con sensori-boa risulta al momento poco efficiente
SHOALING: fenomeno per cui l’onda di uno tsunami cresce progressivamente con l’avvicinarsi alla linea di costa. Con l’alzarsi del fondo marino, infatti, l’onda diminuisce la sua velocità ma, per il principio della conservazione dell’energia, aumenta di conseguenza la sua altezza. Definito anche, in italiano, come “effetto secca”
SORGENTE TSUNAMIGENICA: il luogo in cui si origina lo tsunami, anche a livello potenziale. Generalmente associata all’area di contatto tra placche, ad una faglia o ad un vulcano, anche sottomarino
SUBDUZIONE: fenomeno geologico per cui una placca litosferica scorre sotto un’altra placca, venendo così trascinata in profondità nel mantello. E’ quanto accade nel Mediterraneo, all’incirca in direzione Est-Ovest (dall’Algeria al Medio Oriente), tra la placca africana e quella euroasiatica
TEMPO DI PERCORRENZA: il tempo necessario alla prima onda di tsunami per percorrere il tratto sorgente-costa per un determinato punto
TERREMOTO: rapido movimento della crosta terrestre dovuto al rilascio di energia all’interno della terra, in un punto ben specifico definito ipocentro, in corrispondenza di una faglia. La sua intensità è misurata tramite la magnitudo, i suoi effetti dalla Scala Mercalli. Il terremoto può essere generato anche da attività vulcanica: celebri a questo proposito i cosiddetti “tremori” che talora possono precedere un’eruzione e rappresentare un fondamentale avvertimento. Il terremoto con magnitudo più elevata mai registrato nel nostro paese, in epoca storica, si sviluppò l’11 Gennaio 1693 nella Sicilia Orientale: 7.4 la sua magnitudo stimata sulla scala Richter
VELOCITA’: le onde di tsunami si muovono con una velocità ricavabile da una semplice formula matematica: v = ?gh dove g è l’accelerazione di gravità ed h la profondità del mare. Dunque, maggiore profondità significa maggiore velocità: ciò spiega anche il raggiungimento di velocità pari a diverse centinaia di km/h (fino a 750-800 km/h) in mare aperto dove però l’onda è generalmente alta soltanto pochi decimetri. Man mano che l’onda si avvicina alla costa, la profondità del mare ovviamente diminuisce: dunque rallenta la velocità e diminuisce pure la lunghezza d’onda. Due fattori fisici allora intervengono a modificare la situazione: il principio di conservazione dell’energia e l’incompressibilità dell’acqua. Fattori che provocano una ridistribuzione dell’energia con il conseguente aumento dell’ampiezza dell’onda (shoaling)
VULCANO: spaccatura della superficie terrestre da cui risale magma. Generalmente associato ad una montagna dalla tipica forma conica (cono vulcanico) creata dall’accumulo nel tempo dei prodotti eruttati. In Italia i vulcani più pericolosi, anche sotto l’aspetto di sorgenti tsunamigeniche, sono Stromboli, Vulcano, Vesuvio, Etna. Da non sottovalutare però i vulcani sottomarini del Tirreno Meridionale come il Marsili, ancora potenzialmente più dannosi in quanto posizionati direttamente in mare aperto
- Lo Speciale di MeteoWeb dedicato agli Tsunami Italiani
BIBLIOGRAFIA E FONTI PRINCIPALI
- ITIC, Tsunami Glossary on-line (www.shoa.cl/oceano/itic/pdf.docs/glossary.html)
- Tinti S., Maramai A., L. Graziani, The New Catalogue of Italian Tsunamis, Natural Hazards, Vol 33, n. 3, 2004
- Tinti S., I maremoti delle coste italiane, Geoitalia, 2007
- UNESCO-IOC, Tsunami Glossary, IOC Information document No. 1221, Paris, UNESCO, 2006
- Zecchi R., Distribuzione delle onde anomale nei mari italiani, Bollettino AIC nr 126-127-128, 2006


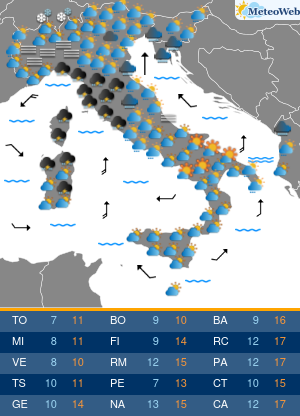


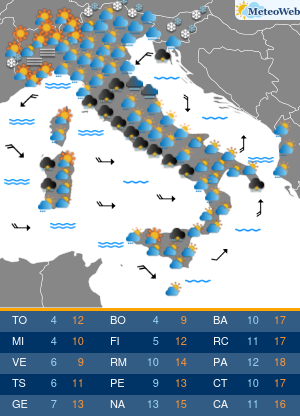


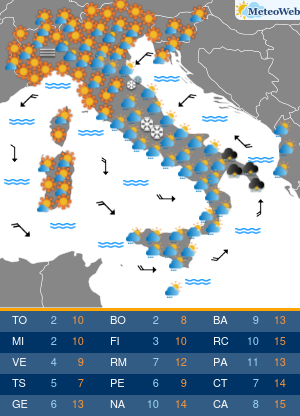


 Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?
Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?