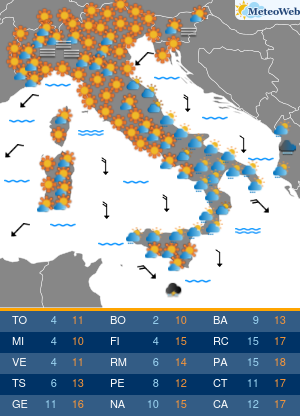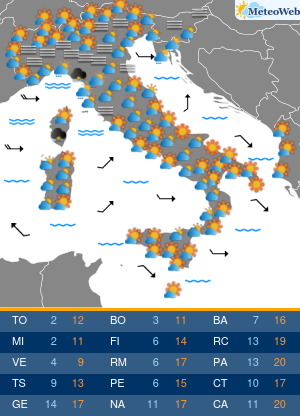di Vittorio d’Oriano – Vice Presidente del Consiglio Nazionale Geologi – Sono tornato nella Valle del Piave, a Longarone. Come sempre, come tutti quelli che conoscono la tragica storia di 50 anni fa, ho rivolto lo sguardo a quella incredibile fessura attraverso la quale il torrente Vajont si getta nel fiume principale; alla diga, alta e imponente, impressionante, apparentemente innocua.
di Vittorio d’Oriano – Vice Presidente del Consiglio Nazionale Geologi – Sono tornato nella Valle del Piave, a Longarone. Come sempre, come tutti quelli che conoscono la tragica storia di 50 anni fa, ho rivolto lo sguardo a quella incredibile fessura attraverso la quale il torrente Vajont si getta nel fiume principale; alla diga, alta e imponente, impressionante, apparentemente innocua.
Mi sono seduto sulla proda del fiume proprio davanti alla diga. La giornata è splendida, i contorni del paesaggio nitidi, e regna un silenzio quasi irreale rotto solo dal rumore del Piave che scorre quasi placido. Il fiume “caro alla Patria” come fu definito all’indomani della prima guerra mondiale per la strenua resistenza che l’esercito italiano oppose agli austriaci dopo la rotta di Caporetto, muto testimone di migliaia di morti e inaudite sofferenze. Ma non meno caro, per le numerosi morti e le altrettanto inaudite sofferenze di cui è stato incolpevole testimone durante la tragedia del Vajont che guarda caso è avvenuta a poco meno di 50 anni di distanza. Che ancora oggi, ad altri 50 anni di distanza, forse scandiscono le giornate dei sopravvissuti e dei loro eredi.
 Non scriverò di geologia, di frane, di assetto della roccia. Non scriverò neppure di responsabilità per le morte inutile di 1910 persone e della distruzione delle loro case, chiese, paesi, orizzonti. Né voglio scrivere di coloro che si salvarono. Senza sapere neanche perché. E che hanno dovuto faticosamente e dolorosamente non ri ma costruire una vita. Che da 50 anni, certamente, sentono, struggente, la nostalgia di quello che avrebbe potuto essere e non è stato.
Non scriverò di geologia, di frane, di assetto della roccia. Non scriverò neppure di responsabilità per le morte inutile di 1910 persone e della distruzione delle loro case, chiese, paesi, orizzonti. Né voglio scrivere di coloro che si salvarono. Senza sapere neanche perché. E che hanno dovuto faticosamente e dolorosamente non ri ma costruire una vita. Che da 50 anni, certamente, sentono, struggente, la nostalgia di quello che avrebbe potuto essere e non è stato.
Non posso non pensare ad una lapide che ho letto lassù, in alto nei pressi della diga, Diga funesta, per negligenza e sete d’oro altrui persi la vita, che insepolta resta ed in particolare il mio pensiero va a quel che insepolta resta. Non ci avevo mai riflettuto ma insepolta va letto nel senso che il corpo di quella persona, e forse di altre centinaia, non fu mai ritrovato e non ha perciò trovato posto nel cimitero allestito a Fortogna. Quel corpo è ancora qua sotto, da qualche parte, sotto i detriti trasportati dell’onda assassina. Forse è proprio sotto dove sono seduto.
 Capisco allora che sono in un cimitero all’aperto, come tutti i cimiteri, ma senza muri di confine e senza cancelli. Quei corpi sono nel paesaggio e del paesaggio.
Capisco allora che sono in un cimitero all’aperto, come tutti i cimiteri, ma senza muri di confine e senza cancelli. Quei corpi sono nel paesaggio e del paesaggio.
Un tempo essere sepolti in terra detta sconsacrata era una pena terribile. Ma qui, tutta questa terra, è stata consacrata da queste morti e dal dolore quotidiano di chi non morì allora.
Penso allora che gli insepolti siano contenti di esserlo perché sono liberi dai lacci degli uomini con le loro passioni inutili, le polemiche svilenti, l’aridità della burocrazia e della legge, l’arroganza della scienza, gli interessi turpi che ancora ci sono a 50 anni di distanza.
Meglio il silenzio, l’aria fresca di questa valle, il cielo azzurro, la corona di montagne che regala agli insepolti un monumento che gli uomini non sarebbero mai stati in grado di costruire.