Almeno una volta ognuno di noi ha sentito una frase del tipo: l’effetto serra influenzerà il clima a scala mondiale nel futuro a breve e lungo termine. Ma che cos’è davvero l’effetto serra? Innanzitutto cominciamo dicendo che la Terra, come qualsiasi corpo caldo emette energia (Fig.1),con un massimo intorno ai 10 µm e consiste di luce infrarossa di lunghezze d’onda comprese tra 4 e 50 µm; tale componente è nota come regione dell’infrarosso termico, perché la sua energia si manifesta come una forma di calore. Alcuni gas presenti nell’atmosfera possono assorbire determinate lunghezze d’onda dell’infrarosso termico, cosicché non tutta la radiazione emessa dall’atmosfera e dalla superficie terrestre sfugge direttamente nello spazio.
Subito dopo essere stata assorbita dalle molecole di gas,questa radiazione infrarossa viene riemessa in tutte le direzioni, anziché univocamente in direzione centrifuga rispetto al nostro pianeta e parte quindi ritorna alla Terra, dove viene riassorbita andando a riscaldarne di nuovo la superficie e l’atmosfera circostante. Il processo si può ripetere n volte, cosicché statisticamente l’energia termica infrarossa verrà trattenuta per un tempo superiore nell’atmosfera rispetto a condizioni di assenza di gas capaci di tale fenomeno. Questo comporterà quindi un incremento della temperatura media atmosferica, il cosi detto effetto serra. Tale fenomeno naturale fa sì che la temperatura media alla superficie terrestre sia di + 15°C anziché di -15°C, rendendo quindi il nostro pianeta compatibile con la vita rispetto al fattore temperatura. Il fenomeno che preoccupa oggi gli scienziati è l’osservato aumento dei gas ad effetto serra negli ultimi due secoli, a partire dalla rivoluzione industriale ed il concomitante aumento, oltre i valori previsti, della temperatura media atmosferica, che ha portato dopo valutazioni critiche ed ampi studi (IPCC 2000, 2007, 2013) a stabilire una relazione tra i due fenomeni (Fig.2).
Misure effettuate sull’aria racchiusa in campioni di ghiaccio prelevati da ghiacciai perenni indicano che la concentrazione dell’anidride carbonica nel periodo preindustriale era approssimativamente uguale a 280 ppm (parti per milione: su un milione di molecole presenti in un campione d’aria, 280 sono di anidride carbonica); entro il 2002, tale concentrazione era aumentata di circa un terzo raggiungendo il valore di 373 ppm (oggi si sono superati i 400 ppm). Il massimo di assorbimento da parte della CO2 delle radiazioni comprese nel campo dell’infrarosso termico si verifica alla lunghezza d’onda di 15 µm. Gran parte del considerevole contributo dell’uomo all’aumento esponenziale della concentrazione atmosferica della CO2 (Fig.3) è dovuta all’utilizzo dei combustibili fossili, soprattutto carbone, petrolio e gas naturale e alla deforestazione, in particolare se realizzata mediante incendi.
L’unico pozzo (sink) a lungo termine per le molecole di CO2 , non soggetto a diretta azione antropica è la loro deposizione nelle profondità delle acque dell’oceano come carbonato di calcio insolubile; tuttavia la scala temporale di questo pozzo permanente è molto lunga, dell’ordine delle centinaia di anni e quindi a differenza della biomassa rappresenta un feedback negativo per l’incremento di CO2 atmosferica molto meno efficace sul breve termine.
Le molecole di acqua, sempre abbondanti nell’atmosfera, assorbono le radiazioni dell’infrarosso termico in conseguenza della vibrazione da flessione del legame H-O-H; il picco nello spettro di assorbimento si trova in corrispondenza della lunghezza d’onda di 6.3 µm. In effetti il vapore acqueo è il principale gas serra dell’atmosfera terrestre, nel senso che esso da luogo ad un effetto serra maggiore rispetto a qualunque altro gas sebbene, per singola molecola, assorba le radiazioni infrarosse meno efficientemente della CO2. La concentrazione del vapore acqueo nell’atmosfera è determinata in primo luogo dalla temperatura e da altri aspetti meteorologici. Praticamente tutta l’H2O presente nella troposfera deriva dall’evaporazione dell’acqua liquida e solida presente alla superficie terrestre e nelle nubi. L’incremento della temperatura dell’aria causato da altri gas serra, riscalda l’acqua e il ghiaccio presenti alla superficie terrestre causando un aumento dell’evaporazione (Fig.4) con un ulteriore aumento del riscaldamento globale per effetto dello stesso vapore acqueo. Questo comportamento dell’acqua è un esempio di un fenomeno generale noto come retroazione (feedback) positiva: il verificarsi di un fenomeno produce un risultato che di per sé rinforza ulteriormente il risultato del fenomeno stesso.
Subito dopo il biossido di carbonio e il vapore acqueo, il metano (CH4) è il terzo in ordine di importanza tra i gas responsabili dell’effetto serra. Il picco di assorbimento dell’infrarosso di questo gas è alla lunghezza d’onda di 7.7 µm. Il pozzo predominante del metano, responsabile di circa il 90% dell’eliminazione di questo gas è la sua reazione in atmosfera con radicali ossidrili (CH4 + OH?> CH3 + H2O). Un altro pozzo, di minore entità, di CH4 atmosferico è l’ossidazione biologica del metano, che avviene prevalentemente nel suolo, ad opera di batteria aerobi chemiautotrofi, i metanotrofi. Circa il 70% delle emissioni totali di metano, che contribuiscono ad aumentare la sua concentrazione atmosferica (Fig.3), ha origini antropiche (combustibili fossili, discariche di rifiuti, combustione di biomassa). Attualmente, una quantità rilevante di metano si trova congelata nel permafrost delle regioni più settentrionali; la fusione del permafrost causato dall’aumento della temperatura planetaria potrebbe immettere nell’atmosfera grandi quantità di questo gas. La fusione del permafrost potrebbe anche causare la decomposizione della materia organica con conseguente immissione di altro metano nell’atmosfera.
Un altro importante gas serra presente in tracce è il protossido di azoto(N2O): la vibrazione da flessione di legame assorbe la radiazione infrarossa in una banda centrata attorno alla lunghezza d’onda di 7.8 µm. Per molecola, l’N2O è 296 volte più efficace della CO2 in termini di capacità radiativa. Come quella del metano, anche la concentrazione atmosferica dell’N2O è rimasta costante fino a circa 300 anni fa, quando ha cominciato ad aumentare, sebbene tale aumento sia stato pari al 13% (Fig.3). Attualmente meno del 40% delle emissioni di protossido di azoto hanno origine dalle attività antropiche e complessivamente l’aumento dell’uso di fertilizzanti in agricoltura probabilmente giustifica grossa parte di queste emissioni. La produzione naturale di tale gas deriva soprattutto dalla sua liberazione dagli oceani, mentre gran parte della quota rimanente è prodotta attraverso una serie di processi biologici, la nitrificazione e la denitrificazione.
Come il CH4 e l’N2O, l’ozono (O3), presente nella troposfera è un gas naturale capace di produrre effetto serra sebbene la sua permanenza nella troposfera sia ridotta. La vibrazione da flessione di legame dell’ozono si verifica a 14.2 µm, in prossimità di quella della CO2,quindi non contribuisce molto all’effetto serra poiché il biossido di carbonio atmosferico assorbe la maggior parte delle radiazioni di questa frequenza.
L’ozono si forma nella troposfera (Fig.5) a causa dell’inquinamento prodotto dalle centrali termoelettriche e dai veicoli a motore, dagli incendi di foreste e praterie e da processi naturali. Per effetto di queste attività umane, i livelli di ozono nella troposfera sono probabilmente aumentati a partire dall’epoca preindustriale. La valutazione più precisa è che circa il 10% dell’aumentato potenziale di riscaldamento dell’atmosfera sia il prodotto dell’incremento di ozono troposferico, sebbene questo valore sia molto incerto.


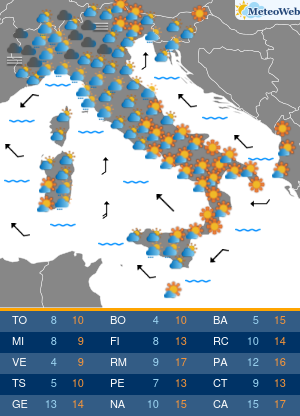


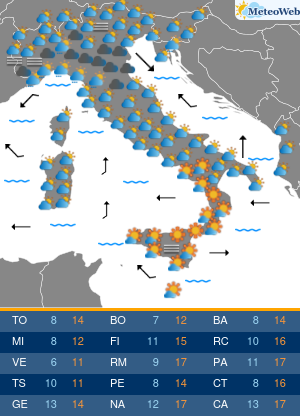


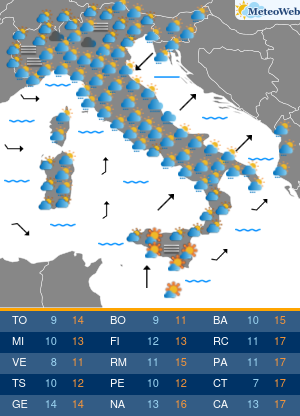


 Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?
Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?