 Il continuo incremento della concentrazione atmosferica dell’anidride carbonica (CO2) è forse il grafico scientifico più comune del ventesimo secolo (Fig.1). C’è un’indiscussa evidenza del fatto che le attività antropiche stiano modificando l’atmosfera terrestre a scala globale e tale certezza è al centro del dibattito sui cambiamenti climatici. Le cause di questo incremento sono oramai ben conosciute: la CO2 è ed è stata emessa dalla combustione di olii fossili, di carbone e di gas, motore delle moderne economie, con un contributo addizionale derivante dalla deforestazione, soprattutto delle foreste tropicali (Malhi Y. and Grace J., 2000).
Il continuo incremento della concentrazione atmosferica dell’anidride carbonica (CO2) è forse il grafico scientifico più comune del ventesimo secolo (Fig.1). C’è un’indiscussa evidenza del fatto che le attività antropiche stiano modificando l’atmosfera terrestre a scala globale e tale certezza è al centro del dibattito sui cambiamenti climatici. Le cause di questo incremento sono oramai ben conosciute: la CO2 è ed è stata emessa dalla combustione di olii fossili, di carbone e di gas, motore delle moderne economie, con un contributo addizionale derivante dalla deforestazione, soprattutto delle foreste tropicali (Malhi Y. and Grace J., 2000).

Queste emissioni sono bilanciate dal naturale sequestro rappresentato dal processo fotosintetico ad opera di piante ed alghe; tale processo utilizza biossido di carbonio ed acqua rilasciando ossigeno nell’atmosfera e incorporando atomi di carbonio all’interno delle cellule vegetali. Negli ecosistemi forestali terrestri la maggior parte del serbatoio (sink) di carbonio è rappresentata dal suolo e dagli alberi; a differenza delle piante annuali che muoiono e vengono decomposte velocemente, le piante legnose sono specie a lunga vita che, sviluppando un’imponente biomassa, sono in grado di inglobare una considerevole quantità di carbonio durante le loro fasi di crescita che dura diverse decadi. In altre parole, il continuo rilascio al suolo di sostanza organica morta e l’assenza di fattori di disturbo, permette l’accumulo di carbonio sotto forma di materia a lenta mineralizzazione (soprattutto derivati della lignina e composti humici). Le foreste dunque operano sia come veicolo per la cattura di carbonio addizionale, sia come riserva a lungo termine dello stesso carbonio (Fig.2).

Le foreste tropicali rivestono un ruolo chiave per il ciclo terrestre del carbonio; esse sono infatti tra gli ecosistemi più produttivi sulla Terra (Grace et al. 2001), contribuendo per il 32-43 % alla produzione primaria netta potenziale a livello mondiale (Melillo et al. 1993). Le foreste tropicali occupano una larga fascia che circonda soprattutto le regioni equatoriali; usando le stime e le definizioni ufficiali della FAO (Food and Agriculture Organization), queste regioni comprendono le foreste pluviali sempreverdi delle piane equatoriali (lowland evergreen rainforests at the equator), molte foreste decidue (deciduous forests), le foreste decidue secche (dry deciduous forests), le foreste di collina e di montagna (hill and mountain forests). In totale, le foreste tropicali e di savana (woody savannas) ammontano al 50 % delle aree forestali a livello globale (Fig.3).
Le foreste tropicali pluviali occupano circa il 10% delle aree forestali del mondo, ma racchiudono il 59% della riserva globale di carbonio nelle foreste (Dixon et al., 1994); in particolare, il ruolo delle foreste pluviali africane nel ciclo globale del carbonio, così come nei cambiamenti climatici, è riconosciuto sempre più (Houghton and Hackler, 2006); Williams et al., 2007), nonostante ci sia ancora una carenza di studi sul ciclo del carbonio nei principali ecosistemi rappresentativi dell’Africa (in particolare proprio nelle foreste tropicali pluviali) e sugli effetti del clima e di fattori esterni (per esempio le deposizioni azotate) sugli scambi di CO2 tra ecosistemi ed atmosfera (Scanlon and Albertson, 2004).

Per molti anni si è ritenuto che le foreste raggiungessero il massimo della loro produttività in un’età intermedia, per poi diminuire in seguito alla maturità, fino a divenire neutre in termini di sequestro di carbonio o addirittura negative, passando da sink, a source (fonte) di carbonio. Tuttavia, negli ultimi anni, questa teoria è stata completamente rivista, dal momento che diversi studi hanno dimostrato come serie di alberi molto vecchi funzionino ancora come sinks di carbonio atmosferico e come questi sinks stiano crescendo ad un ritmo accelerato (Lewis et al.2009). Ciò è stato confermato dagli ultimi risultati di Ciais et al. (2008), il quale ha dimostrato come nell’ultima decade l’Africa sia stata probabilmente un sink netto di carbonio, in contrasto con le precedenti stime di Williams et al. (2007).
I cambiamenti nelle condizioni di crescita degli alberi potrebbero avere un notevole impatto sui cicli atmosferici e biogeochimici, sui cambiamenti climatici e sulla biodiversità; tali cambiamenti potrebbero tuttavia essere attribuiti a molte e diverse cause, per esempio variazioni climatiche favorevoli o un recupero da un fattore di disturbo. Sean M. McMahon et al. (2010), usando un set unico di dati sulla biomassa, campionati negli ultimi 22 anni da 55 siti in foreste temperate e conoscendo la storia dell’utilizzo del suolo (land-use) e il range di vita degli alberi da 5 a 250 anni, hanno evidenziato come il recente accumulo di biomassa abbia ecceduto notevolmente il tasso di crescita che si sarebbero aspettati considerando il solo recupero naturale. Essi hanno inoltre collezionato oltre 100 anni di misure locali meteorologiche e 17 anni di misure in sito della CO2, rilevando un consistente incremento in linea con i trend climatici mondiali. Combinando queste osservazioni, hanno ipotizzato come i cambiamenti a scala globale nella temperatura e nella CO2, possano fondamentalmente alterare il tasso dei processi critici naturali, così come previsto dai modelli biogeochimici. Identificare questo tasso di modifica e le sue cause è importante per la ricerca sullo stato attuale del sequestro e dei flussi di carbonio, i quali influenzano tutt’ora ed influenzeranno lo stato dell’atmosfera e della biosfera.


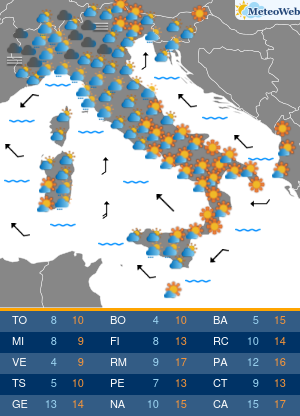


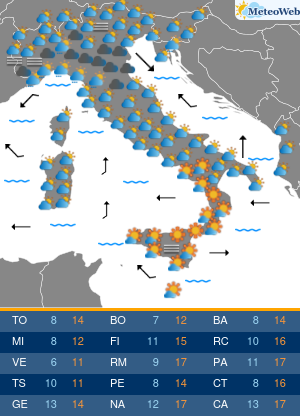


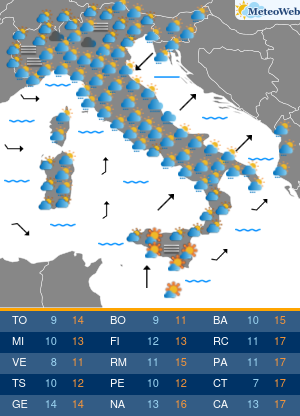


 Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?
Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?