 Chi di noi non conosce la rosa dei venti? Almeno una volta abbiamo visto una sua rappresentazione o ne abbiamo quantomeno sentito parlare. Eppure non tutti conoscono la sua etimologia, per non parlare poi dei nomi dei venti. Perché dunque la rosa dei venti è chiamata così? Il nome è dovuto alla disposizione dei rombi che la compongono e che in origine indicavano le direzioni da cui soffiano i venti; i rombi sono infatti disposti in cerchio e parzialmente sovrapposti gli uni agli altri come appunto avviene per i petali di una rosa. Le quattro punte principali indicano i punti cardinali (in senso orario: Nord, Est, Sud e Ovest); le successive quattro punte indicano invece i punti intercardinali (Nord-Est, Sud-Est, Sud-Ovest e Nord-Ovest). I nomi dei quattro venti provenienti dai punti intercardinali, si devono ai navigatori veneziani, che presero come riferimento un punto fissato nel Mar Ionio, fra la penisola italica e quella greca: così chiamarono Grecale il vento di Nord-Est, perché rispetto al punto fissato proveniva dalla Grecia; Maestrale il vento di Nord-Ovest, proveniente da Venezia, la Maestra; Scirocco quello di Sud-Est, proveniente dalla Siria; Libeccio quello di Sud-Ovest, dalla Libia.
Chi di noi non conosce la rosa dei venti? Almeno una volta abbiamo visto una sua rappresentazione o ne abbiamo quantomeno sentito parlare. Eppure non tutti conoscono la sua etimologia, per non parlare poi dei nomi dei venti. Perché dunque la rosa dei venti è chiamata così? Il nome è dovuto alla disposizione dei rombi che la compongono e che in origine indicavano le direzioni da cui soffiano i venti; i rombi sono infatti disposti in cerchio e parzialmente sovrapposti gli uni agli altri come appunto avviene per i petali di una rosa. Le quattro punte principali indicano i punti cardinali (in senso orario: Nord, Est, Sud e Ovest); le successive quattro punte indicano invece i punti intercardinali (Nord-Est, Sud-Est, Sud-Ovest e Nord-Ovest). I nomi dei quattro venti provenienti dai punti intercardinali, si devono ai navigatori veneziani, che presero come riferimento un punto fissato nel Mar Ionio, fra la penisola italica e quella greca: così chiamarono Grecale il vento di Nord-Est, perché rispetto al punto fissato proveniva dalla Grecia; Maestrale il vento di Nord-Ovest, proveniente da Venezia, la Maestra; Scirocco quello di Sud-Est, proveniente dalla Siria; Libeccio quello di Sud-Ovest, dalla Libia.

La tramontana ad esempio è un vento freddo e secco proveniente da Nord, più frequente nei mesi invernali. Con condizioni di alta pressione sull’Europa Occidentale e di bassa su quella Orientale, viene a crearsi un canale di correnti fredde con direzione Nord-Sud, che dall’Europa centrale o settentrionale giungono fin sull’Italia. Il nome deriva dall’aggettivo tramontano, cioè “oltre il monte”, che in questo caso si riferisce a un vento che proviene da oltre le Alpi, quindi da settentrione. Come recita un canto popolare del Basso Lazio: “Io sòn Gennaio rigido assai, tutti quanti faccio tremare….e per la troppa tramontana vado vestito tutto di lana”. La Val Padana e le vallate alpine invece, che si trovano sottovento a questa circolazione, sono spesso interessate da venti di caduta noti come Foehn (dal tedesco Föhn)o favonio (Fig.2): l’aria nel discendere l’arco Alpino, si comprime e si riscalda, giungendo sul versante italiano come vento asciutto e caldo. Sia favonio che Föhn derivano dal latino fav?nius, vento tiepido. Il nome è conservato nella regione delle Alpi, degli Appennini e degli altri rilievi maggiori della penisola italiana e della Svizzera italiana con il significato attuale.
La Bora (da boreale, settentrionale) è un vento molto freddo proveniente da Nord-Est. Si genera a seguito del forte gradiente barico tra l’Europa Centro-Orientale, occupata da un anticiclone e i bacini centro-meridionali Italiani, divenuti sede di una depressione. Questa configurazione sinottica è tipica del periodo tra Ottobre e Marzo. D’Inverno la Bora, che nelle regioni centrali e meridionali prende il nome di Grecale, è la principale responsabile delle ondate di freddo che interessano la Penisola Italiana. Generalmente al Nord e sulle regioni tirreniche centrali, le correnti da Nord- Est apportano tempo freddo e asciutto con cieli sereni (Bora chiara), mentre causano precipitazioni, nevose a quote basse, sulle regioni centrali adriatiche e al Meridione. Quando la depressione è invece sufficientemente estesa e profonda da avvolgere con i suoi fenomeni anche il Triveneto, si parla di Bora scura.
Il Levante, in riferimento al sorgere del sole, prende il nome dal punto cardinale da dove spira, Est. Si genera quando si forma una depressione tra le coste Africane e le Isole Maggiori o sullo Ionio Meridionale. La depressione richiama correnti orientali dai Balcani verso l’Italia, analogamente a quanto accade con la bora, anche se in questo caso le correnti associate sono generalmente meno fredde.
Il vento proveniente da Sud viene chiamato Ostro, termine che deriva dal latino auster, vento australe. La configurazione barica e la fenomenologia associata sono molto simili allo Scirocco. Quest’ultimo è uno dei venti che più frequentemente spirano sui nostri bacini. È un vento tiepido d’Inverno e nel tardo Autunno, caldo negli altri periodi dell’anno. Si genera quando una depressione avanza da Ovest nel Mediterraneo Occidentale, mentre un anticiclone è posto ad Est, tra il Mediterraneo Orientale e la Penisola Balcanica. In origine il vento di Scirocco è caldo e secco, ma nell’attraversare il Mediterraneo, giunge umido sulle nostre regioni apportando nuvolosità e fenomeni specialmente sulle regioni settentrionali (effetto Stau, vento umido ascendente, Fig.2). Al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, questo tipo di circolazione apporta consistenti rialzi termici. Se lo Scirocco raccoglie grandi quantità di sabbia dal Sahara, può dar luogo ad una colorazione giallognola o rossastra delle nubi e a precipitazioni contenenti molto pulviscolo. In Estate, lo Scirocco si associa spesso alla rimonta sul Mediterraneo dell’ Alta Pressione Africana: con questa situazione sinottica apporta intense ondate di calore, che interessano l’intero territorio nazionale.

Il Libeccio è uno dei venti più frequenti nel panorama meteorologico Italiano. Spira da Sud-Ovest ed è attivato dal passaggio delle perturbazioni atlantiche o dalla formazione di un minimo barico sull’ Alto Tirreno o sul Mar Ligure, similmente a quanto accade con il Ponente (“dove tramonta il sole”), che spira invece da Ovest. Provoca intense precipitazioni specialmente sui versanti Tirrenici e sul Triveneto, esposti alle correnti Sud-Occidentali. È frequente durante le stagioni intermedie ed in Inverno. In Estate, in presenza di alta pressione sul Sud Italia, le correnti di Libeccio tendono a dare effetti simili al Foehn sul versante Adriatico (Garbino, dall’arabo gharb? ovvero occidentale, acquisito dalla lingua turca in età ottomana.. (Fig.3). In genere l’effetto è minore rispetto a quanto accade sulle Alpi, ma se alla compressione dovuta alla caduta, si associa la subsidenza prodotta dall’ Anticiclone Africano, si possono raggiungere picchi termici elevatissimi sui versanti Ionici e del Medio-Basso Adriatico.
Il Maestrale (Mistral dall’antico provenzale Maestral) è un vento che spira da Nord-Ovest. Può soffiare sia in presenza di una rimonta dell’Alta Pressione delle Azzorre sul Mediterraneo Occidentale, sia per un’ irruzione di aria fredda artica che entra nel Mediterraneo Occidentale attraverso la Valle del Rodano. Spesso è responsabile di burrasche ed intense mareggiate sui mari intorno la Sardegna e la Corsica (Fig.3).
Adesso che siamo dunque a conoscenza della direzione di provenienza dei principali venti in Italia, quando useremo espressioni del tipo: “va dove ti porta il vento”…..potremmo anche essere più precisi a riguardo e parlare ad esempio di grecale qualora la persona in esame fosse un freddòfilo, o di scirocco se ci stiamo invece riferendo ad un termofilo.


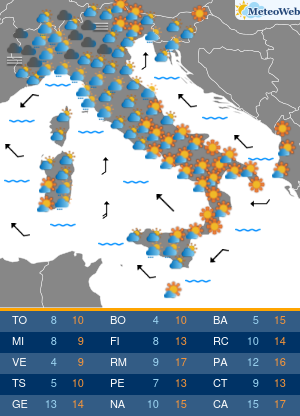


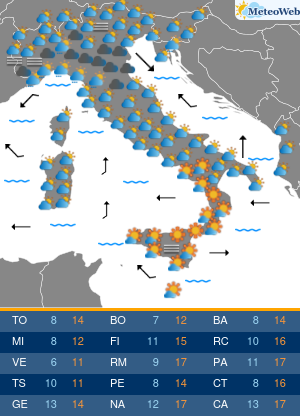


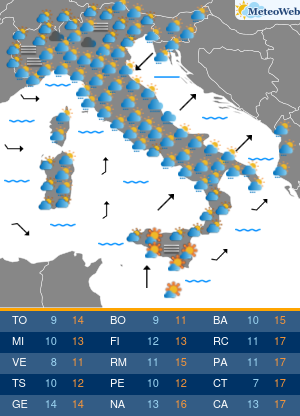


 Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?
Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?