I temporali rientrano sicuramente tra i fenomeni atmosferici estremi più diffusi (secondo alcune statistiche ogni anno si verificano circa 16 milioni di temporali su tutto il globo, Fig.1) e per molti di noi rappresentano un evento suggestivo e minaccioso allo stesso tempo; quanti di noi durante una notte temporalesca sono rimasti indecisi se ammirare “il gioco di luci” alla finestra o restare “al sicuro” nel letto sotto le coperte.
Un temporale è un fenomeno meteorologico complesso, generalmente locale, di breve durata e caratterizzato da forti turbolenze e repentine variazioni di pressione. Può manifestarsi con forti raffiche di vento, con rovesci di pioggia o di grandine, ed è sempre accompagnato da scariche elettriche (elettrometeore). Il temporale si produce in genere nei cumulonembi (dal latino nimbus, tempesta), nubi a sviluppo verticale di diametro fino ad un centinaio di km e di altezza fino a 10-12 km; esso si sviluppa in tre fasi (Fig.2).
(A) Fase di cumulo (o di formazione). Per la presenza di forti correnti ascensionali (10-15 m/sec), un cumulo si trasforma in cumulonembo che assume la caratteristica forma “a cavolfiore”, torreggiante. Le intense correnti ascensionali mantengono in sospensione, all’interno della nube, le gocce di acqua ed i cristalli di ghiaccio che si sono formati. In questa fase sono presenti solo moti ascensionali che in circa 10-15 minuti fanno raggiungere alla sommità della nube la quota di 7-9 km. Le goccioline di acqua in sospensione aumentano sempre di più le loro dimensioni fino a quando il loro peso supera la spinta verso l’alto della corrente ascendente e cominciano a precipitare dando luogo alla seconda fase.
(B) Fase di pioggia (o di massimo sviluppo). Le goccioline di acqua cadendo originano correnti discensionali fredde che colpiscono il suolo e divergono. Nella parte iniziale di questa fase sia le precipitazioni che le correnti discensionali interessano la parte bassa e centrale della nube e gradualmente si estendono a tutta la nube eliminando i moti ascensionali. Le correnti ascendenti raggiungono valori dell’ordine di 30 m/sec. La durata di questa fase è mediamente di 30 minuti e la nube può raggiungere anche i 12 km di altezza.
(C) Fase di dissolvimento. In questa fase sono presenti solo moti ascendenti che trasportavano aria calda e umida verso la nube stessa, che si dissolve a cominciare dalla parte superiore che tende a mescolarsi con l’aria circostante facendole assumere la classica forma ad incudine dai contorni sfilacciati. Le precipitazioni perdono il carattere di rovescio e la temperatura della nube tende a livellarsi con lo stesso valore dell’aria circostante.
I temporali possono essere divisi in due categorie: frontali e temporali di masse d’aria. I temporali frontali sono generati dal sollevamento di masse d’aria lungo le superfici frontali (all’interfaccia tra due masse d’aria con differenti caratteristiche soprattutto termiche). Questi a loro volta possono essere classificati in: (A) Temporali di fronte freddo. Sono i più violenti, generati dall’aria fredda che incuneandosi sotto l’aria calda la solleva bruscamente innescando il moto convettivo che porterà alla formazione della nube temporalesca. (B) Temporali di fronte caldo. Si sviluppano all’interno del sistema nuvoloso stratiforme caratteristico del fronte caldo quando vi è instabilità. Generalmente si sviluppano a quote superiori ai precedenti. (C) Temporali prefrontali. Sono estremamente violenti e generalmente sono presenti nel settore caldo di cicloni attivi, precedendo di circa 100 km i fronti freddi particolarmente vigorosi. Formano la così detta linea di groppo (Squall Line, Fig.3)
I temporali di masse d’aria si originano all’interno di masse d’aria omogenee in presenza di condizioni di instabilità atmosferica. Sono generalmente associati a singoli cumulonembi ben visibili anche da lontano. Possono essere suddivisi in: (1) temporali termoconvettivi. Sono i più comuni e trovano la loro origine nei moti termoconvettivi che, in presenza di un adeguato contenuto di vapore, danno luogo allo sviluppo della nube temporalesca. Questi temporali hanno carattere prettamente locale. (2) Temporali orografici. Sono generati da un iniziale sollevamento forzato della massa d’aria costretta a scorrere lungo il pendio del rilievo. Si localizzano lungo le catene montuose dove danno luogo a forti precipitazioni e severa turbolenza. (3) Temporali di avvezione convergenti. Generati dalla convergenza di masse d’aria, sono generalmente localizzati nel settore caldo di un ciclone.
Un temporale si sviluppa quindi solo se si ha la concomitanza delle seguenti condizioni:
- l’aria risulta instabile;
- presenza di una azione di sollevamento;
- l’aria ha un adeguato contenuto di vapore al suo interno.
Altra caratteristica fondamentale dei temporali è la turbolenza: le correnti ascendenti nelle nubi temporalesche e soprattutto nei temporali di fronte freddo, possono infatti raggiungere una velocità molto alta, superiore a 30 m/s. Naturalmente queste correnti sono compensate da correnti discendenti altrettanto intense. Dopo le recenti ricerche su questo argomento, è risultato errato considerare l’ascendenza nei cumulonembi come una colonna d’aria del tutto regolare. Si tratta piuttosto di una serie di grosse bolle d’aria calda ascendenti, tra le quali l’atmosfera è perturbata da moti vorticosi e da zone di discendenza, una sorta di vero e proprio ribollimento. Il pericolo della turbolenza è più alto alle medie altitudini, tra i 4000 e i 6000 m; tuttavia la turbolenza risulta particolarmente intensa anche sotto la nube a causa dell’alternarsi delle correnti ascendenti e discendenti.
Un discorso a parte meritano i così detti MCS (mesoscale convective system) e gli MCC (mesoscale convective complex), (Fig.4). I primi sono dei temporali di notevole grandezza multicellulari fusi insieme, nati dall’unione di diverse celle ravvicinate tra loro in diversi stadi evolutivi. La fusione di più MCS da a sua volta origine agli MCC, sistemi molto rari poiché si sviluppano in situazioni molto particolari ed in contesti di elevata instabilità. Da satellite gli MCC appaiono come grossi sistemi nuvolosi tondeggianti, ovali o ellittici, che possono estendersi anche per centinaia di chilometri. Spesso si generano al passaggio di intensi CUT-OFF (gocce fredde isolate) che provocano consistenti e rapidi raffreddamenti nell’alta troposfera.
La complessità di questi fenomeni rivela quanto l’atmosfera debba lavorare per regalarci, ancora una volta, un autentico spettacolo della Natura.



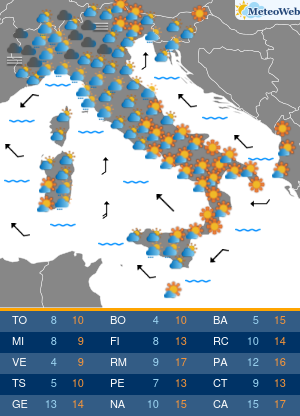


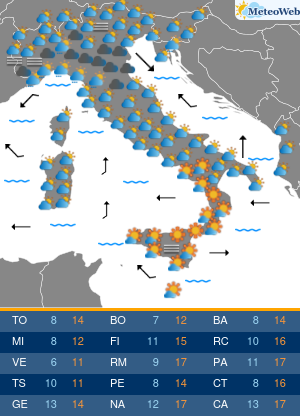


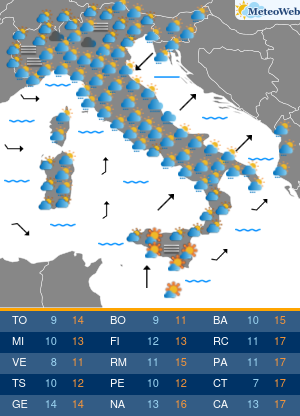


 Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?
Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?