L’acqua è il liquido più diffuso e la sostanza più importante sulla Terra. Si usa per bere, per lavarsi, in essa si nuota e di essa ci si lamenta quando piove! L’acqua influisce sulla vita in molti modi: determina dove si può vivere, il tempo che farà, se è possibile far crescere il raccolto e produrre abbastanza cibo, mentre grandi quantità d’acqua vengono usate anche nell’industria (per esempio, nei processi di raffreddamento delle grandi centrali elettriche o come solvente). Il sistema climatico planetario comprende oltre all’atmosfera anche l’idrosfera, la criosfera (ghiaccio e neve), la litosfera e la biosfera, intesa quest’ultima come complesso degli esseri viventi (animali e vegetali).
Tutti questi componenti hanno un ruolo preciso nel determinare il clima della Terra, ma è soprattutto l’idrosfera (cioè l’insieme dell’acqua presente nel pianeta) che svolge un ruolo fondamentale, contribuendo ad accumulare ed a ridistribuire il calore che proviene dal Sole. L’acqua allo stato libero, cioè non legata chimicamente ad altri elementi, può presentarsi in natura sotto forma solida, liquida o gassosa. Principali sedi di residenza sono gli oceani che ricoprono circa il 71% della superficie del globo e contengono oltre il 97% dell’acqua presente allo stato libero sul pianeta. Di ciò che resta, circa il 2% si concentra nei ghiacci dell’Antartide e della Groenlandia e circa l’1% si raccoglie e scorre sulla superficie o nel sottosuolo dei continenti. Nell’atmosfera infine, sotto forma di vapore, è contenuto soltanto lo 0,001%. Tuttavia, è l’acqua presente in questi due ultimi ambienti che consente la vita sulle terre emerse.
Il trasferimento da una sede all’altra di questa sostanza è causato dalla radiazione solare che, provocando un aumento di temperatura, dà luogo alla trasformazione del ghiaccio in acqua e dell’acqua in vapore e in nubi. Inoltre, generando differenze di temperatura e quindi di densità tra le masse d’acqua o d’aria, ne determina il movimento e il trasporto in zone più fredde ove si verificano i fenomeni opposti di congelamento e di condensazione del vapore che ricade sotto forma di pioggia, grandine o neve. Pur esistendo continui trasferimenti di acqua da uno stato fisico all’altro, da una sede di residenza all’altra, le percentuali medie sopracitate, valutate su tempi sufficienti a caratterizzare il clima (alcune decine di anni), si mantengono costanti per periodi confrontabili con i tempi di evoluzione del clima a scala planetaria.
Si può dire al riguardo, con sufficiente sicurezza, che le percentuali sopraindicate hanno subìto modifiche nel corso delle ere geologiche ed in particolare nell’ultimo milione di anni con l’avvicendarsi dei periodi glaciali e interglaciali. La distribuzione attuale può farsi senz’altro risalire nel tempo a circa 10.000 anni or sono, allorché il pianeta si è assestato sulla attuale fase climatica calda.
Questa affermazione deriva dal fatto che la quantità d’acqua presente sulla Terra non varia, se non in modo trascurabile. Si è stabilito, inoltre, un equilibrio dinamico che ha dato luogo a trasferimenti che su tempi lunghi sono praticamente nulli, poiché nei vari passaggi le quantità in gioco tendono a bilanciarsi. L’insieme dei flussi dell’acqua da una sede di residenza all’altra è comunemente chiamato ciclo idrologico (o ciclo dell’acqua, Figura 1).
Lo schema è il seguente: per effetto dell’evaporazione (trasferimento diretto dell’acqua dallo stato liquido a quello di vapore), dell’evapotraspirazione (emissione di vapore in aria per i cicli metabolici delle piante) e della sublimazione (trasferimento diretto dell’acqua dallo stato solido a quello di vapore), si ha il passaggio di acqua dalla superficie terrestre all’atmosfera. Una volta in aria il vapore viene trasportato in regioni diverse da quelle in cui si è prodotto e sotto particolari condizioni può condensare dando luogo ai sistemi nuvolosi. Questi ultimi a loro volta danno origine alle precipitazioni liquide o solide e il ciclo in questo modo si chiude.
In sostanza le vicende e le condizioni meteorologiche che si registrano sul nostro pianeta con la loro mutevolezza fanno sì che si verifichi un continuo spostamento dell’acqua da una sede di residenza all’altra, dall’oceano e dalle terre emerse all’atmosfera, da questa di nuovo verso l’oceano, le acque interne (fiumi, laghi, falde) e il suolo attraverso i processi di cui si è prima fatto cenno.
Considerando innanzitutto gli oceani, che sono la maggiore riserva d’acqua libera, si vede che l’evaporazione totale dalla loro superficie è di circa 455.000 km 3 all’anno. Allo stesso tempo, l’evaporazione totale dal suolo, dalle piante (evapotraspirazione), e dalle superfici d’acqua presenti sui continenti è di circa 62.000 km 3. Quindi il termine di evaporazione totale è di 517.000 km3.
Questa rappresenta la quantità d’acqua che deve ricadere annualmente allo stato solido o liquido. La precipitazione avviene in maniera non uniforme su continenti e oceani: 108.000 km 3 cadono sulle terre emerse; 409000 km3 sulla superficie oceanica. Dalla differenza tra evaporazione e precipitazione si ricava che i continenti ricevono per precipitazione circa 46.000 km 3 di acqua in più rispetto a quella che perdono per evaporazione. Questa eccedenza, che scorre sulla superficie terrestre o penetra nel sottosuolo raggiungendo il mare per vie diverse, rappresenta il termine comunemente chiamato deflusso (acqua di scorrimento). In compenso i bacini oceanici perdono per evaporazione circa 46.000 km 3 di acqua in più rispetto a quella che ricevono per precipitazione
A livello planetario il ciclo dell’acqua è strettamente connesso ai grandi flussi di energia nell’atmosfera. Il volume totale di acqua presente nell’atmosfera (Figura 2) è stato stimato in circa 1.3 x 10 13 m 3 (13 mila km 3), per gran parte nella fase di vapore; mentre negli oceani sono contenuti circa 1.35 x 10 18 m 3di acqua (1350 milioni di km 3).
Il rapporto tra i volumi di acqua nell’atmosfera e negli oceani è 1/100000 (circa lo stesso rapporto tra l’acqua contenuta in un ditale e quella in una vasca da bagno). Nonostante ciò, il vapor d’acqua atmosferico è uno dei più importanti fattori nel determinare il tempo ed il clima, soprattutto per la grande quantità di energia messa in gioco quando l’acqua cambia il suo stato di aggregazione tra la fase gassosa (vapore), liquida e solida, e per il suo contributo come gas responsabile dell’effetto serra.
Il riscaldamento differenziato della superficie terrestre da parte del Sole crea le condizioni alla base dei grandi trasferimenti di masse d’aria tra Equatore e Poli. Mentre le regioni equatoriali ricevono più calore di quello che perdono, le zone più vicine ai Poli perdono più calore di quello che ricevono. Due fondamentali correnti di convezione di alta quota (simmetriche, dall’Equatore verso i due Poli) distribuiscono in maniera più equilibrata il calore. Un ruolo importante in questo trasporto di calore e quindi di energia è legato all’acqua. Essa evapora nelle zone equatoriali, viene trasportata a seguito delle masse d’aria verso i Poli sotto forma di vapore e condensa nelle nubi. Infine, precipita sotto forma di pioggia o neve, che la riportano di nuovo sulla superficie terrestre e quindi nei mari.


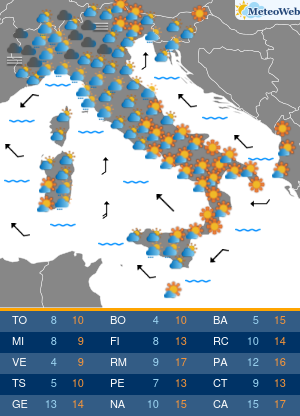


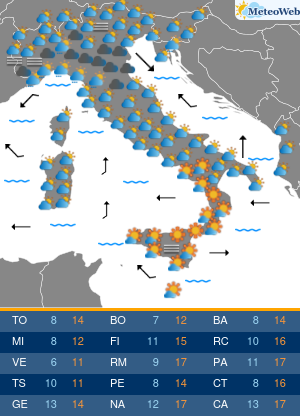


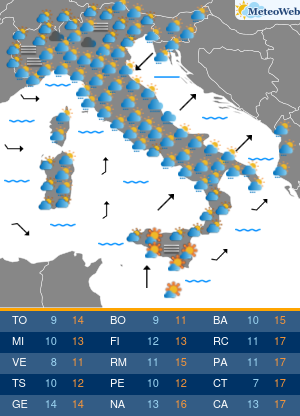


 Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?
Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?