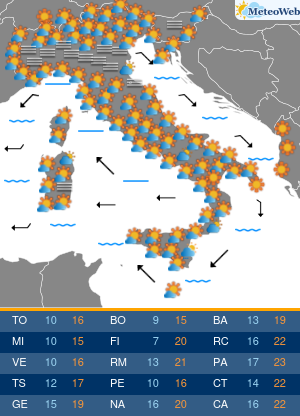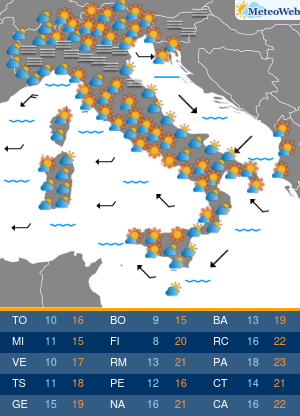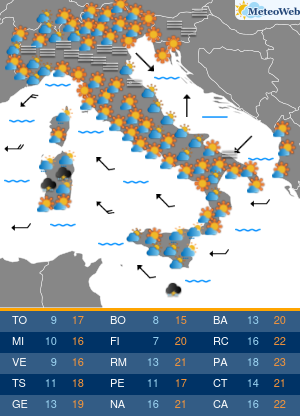Solo il 10% dei casi di tumore del fegato è diagnosticato in fase iniziale quando l’intervento chirurgico può essere risolutivo. In Italia vivono circa 27.745 cittadini dopo la diagnosi di questa neoplasia, che rappresentano l’1% del totale dei pazienti oncologici.
Si tratta di un tumore con percentuali di guarigione ancora basse, infatti solo il 20% è vivo a cinque anni dalla diagnosi. Oggi per i pazienti con malattia avanzata già trattati si stanno aprendo importanti prospettive terapeutiche, tra queste cabozantinib, una nuova terapia mirata. Lo dimostrano i risultati dello studio fase III CELESTIAL, discussi al 54° Congresso dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO) in corso a Chicago.
“Nella ricerca sono stati arruolati più di 700 pazienti con carcinoma epatocellulare avanzato, precedentemente trattati – spiega Lorenza Rimassa,Responsabile della Sezione Tumori Apparato Gastroenterico, Oncologia medica ed Ematologia dell’Humanitas di Rozzano -. L’Italia ha avuto un ruolo decisivo in questa ricerca, con l’Istituto Humanitas in primo piano. Cabozantinib ha dimostrato un miglioramento statisticamente significativo e clinicamente importante rispetto al placebo nella sopravvivenza globale, in pazienti in seconda (70% del totale) e terza linea (30%). La sopravvivenza globale mediana è stata 10,2 mesi con cabozantinib rispetto a 8 mesi con placebo. E la mediana di sopravvivenza libera da progressione era più che raddoppiata: 5,2 mesi con cabozantinib e 1,9 mesi con placebo”.
In Italia nel 2017 sono stati diagnosticati 12.900 nuovi casi di cancro del fegato (8.900 uomini e 4.000 donne). In controtendenza rispetto alle altre neoplasie, questo tumore fa registrare un maggior numero di diagnosi nel Sud Italia rispetto al Settentrione, in particolare fra le donne (+17%). Il dato si spiega con la prevalenza in queste aree delle infezioni causate dai virus dell’epatite B (HBV) e C (HCV).
Questi virus sono le principali cause della neoplasia a livello globale, insieme all’alcol e alla sindrome metabolica. In Italia oltre il 70% dei casi di tumori primitivi del fegato è riconducibile a fattori di rischio noti, collegati soprattutto al virus dell’epatite C. Un’elevata percentuale di persone che contraggono questa infezione, stimata fino all’85%, va infatti incontro a cronicizzazione. Il 20-30% dei pazienti con epatite cronica C sviluppa, nell’arco di 10-20 anni, cirrosi e, in circa l’1-4%, successivo epatocarcinoma.
“Per 10 anni nel trattamento di questa patologia è stata disponibile una sola terapia mirata, sorafenib, ma negli ultimi due anni lo scenario terapeutico si è arricchito con nuove armi – continua la dott.ssa Rimassa -. Nello studio CELESTIAL sono stati arruolati pazienti che avevano ricevuto una o due linee di terapia ed erano andati in progressione dopo uno dei trattamenti precedenti. Per la prima volta oggi per i pazienti intolleranti a sorafenib e in terza linea di trattamento possono esserci reali opzioni terapeutiche”.
“La maggior parte dei pazienti presenta già una patologia, in particolare cirrosi, che ha determinato lo sviluppo del tumore – sottolinea la dott.ssa Rimassa -. Da qui le maggiori difficoltà nel trattare questa neoplasia. Solo in una minima percentuale di casi il tumore insorge in un fegato sano, e in questi pazienti la diagnosi è spesso tardiva con sintomi già evidenti per la presenza di metastasi a distanza o per lesioni epatiche estese”.
Il tumore può essere trattato con chirurgia, trapianto di fegato o terapie locoregionali (ad esempio ablazione, chemioembolizzazione, ecc) finché rimane localizzato al fegato. “In realtà i pazienti spesso dovrebbero accedere prima alle terapie sistemiche – conclude la dott.ssa Rimassa -. È infatti forte il dibattito nella comunità scientifica su quando effettuare il passaggio dai trattamenti locoregionali a quelli sistemici. Un altro problema da affrontare è, ad oggi, l’assenza di biomarcatori per selezionare i pazienti candidabili a una specifica terapia. Il futuro della ricerca va proprio in questa direzione”.